Marta Tibaldi
Le parole che curano: il potere archetipico del linguaggio
Roma, settembre 2001 [1]
Caro Dottor Hillman, non “Caro James”, per carità!, infatti anche se avessi con lei un rapporto di amicizia e di familiarità non rinuncerei a scriverle con la forma di cortesia, per segnalarle il rispetto che provo per un 'grande' della psicologia analitica, quale lei è. Il rispetto, ma anche l'ammirazione per l'originalità e per la 'divergenza' del suo pensiero, è ciò che sento e che mi lega a lei: allo James Hillman reale, quello che ho conosciuto a Sant'Andrea in Percussina in occasione dei seminari di Anima, e all'immagine di James Hillman, quella che si è costruita nella mia mente nel corso del tempo, piuttosto lentamente direi, attraverso la lettura dei suoi scritti e l'efficacia delle sue parole. James Hillman reale, dunque, e James Hillman come immagine interna; in entrambi i casi una figura das wirkt, come direbbe Jung, “che agisce” nella mente, dando, almeno per quel che mi riguarda, piacere all'Io e benessere all‟anima.
Per questi motivi l'occasione che ho di scriverle rappresenta per me a pleasure and a privilege, come si direbbe nella sua lingua. Un piacere e un privilegio di cui non posso che esserle grata. Quando mi è stato chiesto di partecipare, anche con la mia lettera, al tentativo di “saggiare criticamente […] i vari aspetti considerati rilevanti dell'opera hillmaniana”, ho pensato: le immagini, le immaginazioni attive, le parole, ecco i luoghi del mio incontro con Hillman. In realtà in questa lettera mi soffermerò soltanto sulle parole; sulla capacità, tutta e tipicamente umana, di comunicare verbalmente, su quel “miracolo di trovare le parole giuste, le parole che comunicano l'anima in modo accurato, dove si intrecciano pensiero, immagine e sentimento [...] ciò che nell'essere umano rappresenta la più complessa impresa psichica che si possa immaginare." (J. Hillman, Re-visione della psicologia (1975), Adelphi, Milano 1993, p. 363).
Avevo iniziato questa lettera prima dei fatti di New York e riprendo a scriverle oggi, pochi giorni dopo la notizia della tragedia che ha sconvolto l'America e che ha trasformato il mondo. Siamo stati testimoni di un evento storico dopo il quale, come molti hanno osservato, tutto è cambiato. Mi accingo dunque a scriverle in un momento in cui nulla è come prima, neanche le parole. In questa lettera avrei voluto scrivere, tra l'altro, su quello che lei definisce “l'aspetto angelico delle parole”: “Le parole, come gli angeli, sono potenze che esercitano su di noi un potere invisibile. Sono presenze personali dotate di intere mitologie: generi, genealogie (etimologie concernenti le origini e le creazioni), storie e voghe; e hanno inoltre specifici effetti protettivi, blasfemi, creativi e annientanti. Poiché le parole sono persone” (Ibid., p. 43); avrei voluto scrivere sulla necessità di 'curare' il nostro linguaggio, ritrovando l'anima delle parole e trasformando nuovamente i concetti in metafore perché, come lei afferma, “La 'cura con le parole' di Freud è anche la cura del nostro parlare, un cimentarsi con il più difficile dei compiti culturali, la rettificazione del linguaggio: la parola giusta” (Ibid, p. 52); avrei voluto scrivere infine su ciò che lei definisce, con un'espressione toccante, il “coraggio di essere eloquenti”. Avrei voluto scriverle tutto questo, ma gli avvenimenti di New York mi spingono a riflettere sull'esperienza che in questi giorni stiamo facendo delle parole. La carica emotiva che si è sprigionata dal crollo delle torri sembra scuotere dalle fondamenta il nostro modo di parlare e di percepire le parole, che riacquistano corpo, forza e autonomia. Mai come in questo momento possiamo prendere coscienza dell'oscurità in cui abbiamo segregato questi ambasciatori dell'inconscio, ai quali abbiamo negato la funzione e la dignità di mediatori psichici. Negando alle parole libertà e autonomia abbiamo privato questi "portatori d'anima" del ruolo di intermediari; letteralizzandone il significato abbiamo impedito all'anima di "saltare fuori dalle frasi" con le sue immagini e le sue storie; riversando su di loro il nostro pregiudizio le abbiamo costrette al silenzio o a parlare nell'unico modo che conoscevamo, il nostro. Abbiamo dimenticato così che le parole giungono a noi come ospiti, nei confronti dei quali abbiamo doveri di ospitalità. Le parole che si offrivano a noi infiammando i sensi e accendendo le menti, queste parole non hanno più parlato. Da quando abbiamo gettato nell'ombra la loro potenza e il loro fascino, esse hanno taciuto e noi siamo orfani delle loro immagini e delle loro storie.
Le parole sono meri strumenti dell'Io, un flatus voci – sosteneva il nominalista Roscellino. Le parole sono nomi, non hanno realtà oggettiva. Abbiamo dimenticato così che gli universali, gli invisibili, gli archetipi – o in qualunque altro modo vogliamo definire ciò che è eccentrico rispetto all'Io – vivono di vita autonoma, che precede l'Io e ne eccede il significato. Abbiamo usato le parole senza rispetto e senza consapevolezza; non ne abbiamo avuto cura, non ce ne siamo sentiti responsabili. Ma, come avviene nella stanza d'analisi, oggi siamo obbligati a riflettere su ciò che diciamo e sul modo in cui lo diciamo, un po' più consapevoli, forse, che la potenza delle parole “trascende la loro definizioni e i loro contesti nominalistici ed evoca nelle nostre anime una risonanza universale”(Ibid, p. 43; cfr. anche M. Tibaldi, L'Ombra delle parole, in Anima Mundi, n. 2/2001.).
A un mese di distanza le mie parole sono oggi molto diverse da quelle di ieri; la carica emotiva degli avvenimenti di New York si è in parte placata, la mente non è confusa come allora, anche se i sentimenti sono molto diversi da quelli iniziali. Nello scrivere questa lettera avrei potuto distanziarmi da quanto accaduto in America, ma ho deciso di non farlo. Che l'anima possa vivere drammaticamente l'impossibilità di dire i propri turbamenti o le proprie gioie in forma verbale lo testimoniano in modo esemplare le parole di una paziente, che in seduta afferma: “Le mie parole sono prigioniere; spingono, premono per venire allo scoperto, ma un diaframma impedisce loro di uscire”. Il suo corpo comunica l'angoscia di non sapersi dare in forma verbale; la paziente vive quella che lei suggestivamente definisce l' “angoscia semantica”: “Quanto più ci sottraiamo al rischio di parlare per l'angoscia semantica che tiene l'anima segregata nel silenzio, privata e personale tanto più si allarga lo iato tra ciò che siamo e ciò che diciamo, la scissione tra psiche e logos” (J. Hillman, Re-visione della psicologia, cit., p. 364). E' proprio sulla parola psicologica, che coniuga insieme pensiero, immagine e sentimento, sulla parola d'anima che comunica le immagini dell‟inconscio individuale e collettivo, che vorrei formulare una riflessione teorica e una considerazione clinica.
Sappiamo quanto in ambito junghiano esista, soprattutto in Italia, una certa e paradossale diffidenza nei confronti della cosiddetta psicologia archetipica, che lei autorevolmente rappresenta (J. Hillman, Psicologia archetipica in L'Immaginale,1987; F. Donfrancesco, Perché psicologia "archetipale", Appendice a J. Hillman, Oltre l'umanesimo, Moretti & Vitali, Bergamo 1996). Tale diffidenza è in parte riconducibile alla presa di distanza dalla nozione di archetipo espressa da Mario Trevi nel suo tentativo di revisione critica dello junghismo (M. Trevi, Per uno junghismo critico, Bompiani, Milano1987). Come è noto, anche in ambito internazionale il concetto di archetipo è stato oggetto di discussioni e ampliamenti in direzione sia di un suo maggiore radicamento sia nella sfera mitologico-immaginale, sia in quella biologica. Nella prima direzione si colloca la sua opera, che radicalizza il significato mitologico dell'archetipo e propone un modello della psiche il cui soggetto principale sia “l'anima”, la base poetica della mente che interconnette gli eventi in modo immaginale (J. Hillman, Anima. Anatomia di una nozione personificata, Adelphi, Milano 1989); nella seconda si colloca il contributo di Anthony Stevens, che in Archetypes: a Natural History of the Self (1982) e nel più recente The Two Million-Year-Old Self (1993) offre un supporto empirico all'ipotesi dell'esistenza degli archetipi, individuandone la base biologica e assimilandoli al concetto di struttura etologica ereditaria propria della moderna biologia. Ciò che colpisce è quanto in ambiti culturali diversi da quello della psicologia analitica, a differenza del pregiudizio che serpeggia a volte tra gli junghiani a proposito della psicologia archetipica, la validità euristica della nozione di archetipo sia pienamente accolta, riconosciuta e utilizzata; si pensi, ad esempio, alla cosiddetta “critica archetipica”, che in letteratura costituisce uno dei quattro più rilevanti orientamenti per studiare e valutare un'opera letteraria; ispirandosi alle teorizzazioni junghiane e agli studi antropologici di James Frazer, la critica archetipica dedica particolare attenzione proprio a quei motivi (archetipi) che nel testo letterario danno forma in modo costante e ricorrente a aspetti fondamentali dell'esistenza (cfr. M. Tibaldi, Critica archetipica, in Le nuove Effemeridi, 2001). Se in ambito letterario la critica archetipica ha accolto e valorizzato soprattutto il versante mitopoietico dell'archetipo, è interessante notare come nell'ambito della ricerca empirica sul processo psicoanalitico, in quello delle neuroscienze, della psichiatria evoluzionistica e della neuropsicologia cognitiva sia stato invece valorizzato il versante biologico della psiche conscia e inconscia, con risultati sperimentali che tendono a confermare, seppure indirettamente e in modo implicito, le intuizioni junghiane sul funzionamento della psiche e l'ipotesi archetipica che sistemi funzionali a base innata, selezionati dall'evoluzione, intervengano nel motivare il comportamento umano: si pensi, ad esempio, ai sistemi motivazionali di Joseph D. Lichtenberg (Psicoanalisi e sistemi motivazionali, Cortina, Milano 1995) al “darwinismo neuronale” e alla “coscienza di ordine superiore” di Gerald M. Edelmann (Neural Darwinism. The Theory of Neuronal Group Selection, Basic Books, New York 1987; Sulla materia della mente, Adelphi, Milano 2000); alle ricerche di Antonio R. Damasio (L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano 1995; Emozione e coscienza, Adelphi, Milano 2000) sulla “coscienza nucleare” e sulla “coscienza estesa”; all'attività referenziale della mente e alla “Teoria del codice multiplo” di Wilma Bucci (Psychoanalysis and Cognitive Science: a Multiple Code Theory, Guilford, New York 1997), ecc. Sebbene in questi studi Jung e i suoi scritti non vengano citati e malgrado siano diversissimi l'impianto metodologico, il registro linguistico e le metafore con cui sono descritti i processi psichici, al lettore attento non sfugge l'affinità tra queste descrizioni e quelle della psicologia analitica. E' da notare inoltre la tendenza di questi studi a convergere verso una teoria complessa della mente: una teoria della mente e del cervello, della coscienza e della cultura, nella quale le mente come la cultura sono frutto del cervello, ma nella quale la cultura come la mente hanno la capacità di retroagire sulle strutture cerebrali, modificandole (A. Oliverio, Biologia e filosofia della mente Laterza, Bari 1995); per dirla in termini junghiani, un modello della psiche nel quale l'archetipo rappresenti "uno spettro che va dal polo 'infrarosso', fisiologico, istintuale al polo 'ultravioletto', spirituale o immaginistico. L'archetipo abbraccia ambedue i poli e può essere sperimentato e compreso attraverso l'uno o l'altro. Gli approcci biologici o etologici all'inconscio si possono caratterizzare come 'infrarossi'; gli approcci mitologici o immaginali come 'ultravioletti' " (A. Samuels, B. Short, F. Plaut, Dizionario di psicologia analitica, Cortina, Milano 1987, p. 72).
E' proprio tenendo conto di tali convergenze teoriche che vorrei estendere anche agli psicologi analisti l'invito che Giovanni Liotti ha recentemente rivolto ai terapeuti cognitivisti, agli psicoanalisti e ai terapeuti della famiglia; quello di riflettere sulla possibilità di edificare una disciplina psicologica e psicopatologica unitaria, fondata sulla riflessione teoria, l'osservazione clinica e la ricerca empirica: “Lo Spirito del Tempo, lo Zeitgeist, ha suscitato, nell'ultimo quarto del secolo appena trascorso, il rapido sviluppo di due campi del pensiero capaci di influenzare profondamente il nostro modo di studiare la psicopatologia e la psicoterapia. […] Forse non è azzardato immaginare che lo Zeitgeist stia suggerendo una base per l'edificazione di una disciplina unitaria, solidamente fondata anche sulla ricerca empirica oltre che sulla riflessione teorica e l'osservazione clinica. In futuro potremo chiamarla 'psicoterapia', senza aggettivi" (G. Liotti, Le opere della coscienza. Psicologia e psicoterapia nella prospettiva cognitivo-evoluzionista, Cortina, Milano 2001). Sono convinta che in un eventuale progetto di riflessione comune il confronto con la singolare capacità dei cosiddetti 'analisti archetipici' di avvicinare immaginalmente il linguaggio psicologico potrebbe rappresentare un contributo fondamentale. L'approccio archetipico alle parole, ovvero una linguistica dell'immaginazione che reimmagini il linguaggio psicologico e curi con parole d'anima il nominalismo della psicologia e della psicopatologia, potrebbe aiutare a divenire più consapevoli del ruolo che le parole svolgono nella psicoterapia: "Nella prassi analitica i complessi psichici del paziente sono trattati con la cura delle parole (talking cure). Tuttavia non soltanto il paziente non è consapevole del ruolo che il linguaggio svolge nella sua personalità, ma anche lo stesso terapista spesso non è consapevole dei sottili effetti che le sue parole hanno sul paziente" (P. Kugler, The Alchemy of Discourse. An Archetypal Approach to Language, Associated University Press, New York 1982, p. 5; la traudzione è mia). Dal punto di vista evolutivo la competenza linguistica è la più evoluta di tutte le facoltà umana ed è senza dubbio, come lei scrive, la più complessa impresa psichica che si possa immaginare; attraverso il recupero clinico della padronanza affettiva, immaginale e cognitiva di questo peculiare strumento umano si può giungere a sviluppare quella che lei definisce "la narrativa che cura", ovvero "la capacità della psicoterapia di guarire, la sua capacità di continuare a ri-raccontarsi in rinnovate letture immaginative delle sue stesse storie” (J. Hillman, Le storie che curano, Cortina, Milano 1984, p. V). Per questi motivi voglio concludere la mia lettera ricordando alcune sue affermazioni a proposito del linguaggio d'anima e l'invito a ritrovare nell'eloquenza, nell'arte di comunicare verbalmente l'essenza del pensiero e delle emozioni, la singolare capacità, tutta e soltanto umana, di "fare anima" con le parole:
"Tutte le moderne terapie che affermano che l'azione cura meglio delle parole (Moreno) e che sono alla ricerca di tecniche diverse dalle parole (invece che di tecniche da aggiungere alle parole) reprimono la più umana di tutte le facoltà: raccontare le storie della nostra anima. Queste terapie sono forse efficaci sul bambino che è in noi, che non ha ancora imparato a parlare, o sull'animale, che non può farlo, o magari su uno spirito-daimon, al di là delle parole perché al di là dell'anima. Ma solo uno sforzo continuo di parlare un linguaggio d'anima accurato può curare il nostro linguaggio delle sue vuote chiacchiere e restituirlo alla sua funzione prima, la comunicazione dell‟anima. […] Più diffidiamo della parola in terapia o della capacità della parola di esser terapeutica, maggiore è il nostro rischio di venire assorbiti nella fantasia del subumano archetipico, e più vicino è l'ingresso imperioso del barbaro archetipico tra le rovine del sistema comunicativo d'una cultura che ha rifiutato l'eloquenza come specchio della propria anima" (J. Hillman, Re-visione della psicologia, cit., p. 364).
Ringraziandola ancora per il piacere e il privilegio di averle potuto scrivere questa lettera, la saluto cordialmente.
Marta Tibaldi
[1] Ho iniziato a scrivere questa lettera prima degli avvenimenti di New York e l‟ho conclusa un mese dopo. Il contenuto e lo stile risentono degli echi di tale frattura. Ho scelto di non modificare la disomogeneità emotiva e stilistica della lettera per rispetto e memoria di quanto accaduto.
Bibliografia
BUCCI, W. (1997), Psychoanalysis and cognitive science: A Multiple Code Theory, New York – London, The Guilford Press 1997;
DAMASIO, A.R. (1994), L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano 1995;
DAMASIO, A.R. (1999), Emozione e coscienza, Adelphi, Milano 2000;
DONFRANCESCO, F. (1996), Perché psicologia 'archetipale, Appendice a HILLMAN J., Oltre l’umanismo, Moretti & Vitali, Bergamo;
EDELMANN, G.M. (1987), Neural Darwinism. The Theory of Neuronal Group Selection, Basic Books, New York 1987;
EDELMANN, G.M. (1992), Sulla materia della mente, Adelphi, Milano 1993;
HILLMAN, J. (1975), Re-visione della psicologia, trad. it. Adelphi, Milano 1984;
HILLMAN, J. (1983), Le storie che curano, Cortina, Milano 1984;
HILLMAN, J. (1987), Psicologia archetipica, in L’immaginale, 1987;
HILLMAN, J. (1985), Anima. Anatomia di una nozione personificata, Adelphi, Milano 1989;
KUGLER, P. (1982), The Alchemy of Discourse. An Archetypal Approach to Language, Associated University Press, Inc., New York 1982;
LICHTENBERG, J. (1989), Psicoanalisi e sistemi motivazionali, trad. it. Cortina, Milano 1995;
LIOTTI, G. (2001), Le opere della coscienza. Psicopatologia e psicoterapia nella prospettiva cognitivo-evoluzionista, Cortina, Milano 2001;
OLIVERIO, A. (1995), Biologia e filosofia della mente, Laterza, Bari 1995;
POPPER, K.R., ECCLES, J.C. (1977), L’io e il suo cervello, Armando, Roma 1978;
SAMUELS, A., SHORTER, B., PLAUT, F. (1986), Dizionario di psicologia analitica, Cortina, Milano 1987;
STEVENS, A. (1982), Archetypes: A Natural History of the Self, Routledge & Kegan Paul, London 1982;
STEVENS, A. (1993), The Two-Million-Year- Old-Self, Texas A & M University Press, College Station 1993;
TIBALDI, M. (2001a), L'Ombra delle parole, in Anima Mundi, ERI, n. 2/2001;
TIBALDI, M. (2001b), Critica archetipica, in Le Nuove Effemeridi;
TREVI, M. (1987), Per uno junghismo critico, Bompiani, Milano 1987.
Risposta a Marta Tibaldi
Leggere la sua lettera mi ha dato molto piacere perché lei sembra essere orientata in una direzione verso la quale ho teso e nella quale ho desiderato stabilirmi senza mai giungervi: intendo la riforma del linguaggio psicologico.
Sebbene io non condivida il suo desiderio utopico di una disciplina unitaria saldamente fondata sulla ricerca empirica (si tratta veramente di un terreno solido oppure di un mucchio di sabbia sempre in movimento?), poiché il linguaggio ha un aspetto angelico. Infatti esso ha un aspetto sui generis di potere anarchico non-unificante… da qui la poesia (dove non può esserci nessuna disciplina unitaria saldamente fondata).
Ma mettiamo tutto ciò da parte, così che possiamo rivolgerci alla sua osservazione principale, "la linguistica dell'immaginazione". Essa è ciò che di cui abbiamo bisogno per la nostra effettiva pratica terapeutica. È ciò che i sogni ci portano di notte e che gli studi umanistici e le arti impiegano per attivare l'anima. Sono curioso di sapere che cosa permette ai terapeuti, piuttosto che seguire le linee che lei ha indicato nella sua lettera, di aggrapparsi ancora alle astrazioni eccessivamente concettuali, alla pseudoscienza e alla nomenclatura diagnostica.
Fortunatamente, un'apertura per questa linguistica dell‟immaginazione – al fine di studiare i complessi e i caratteri dei nostri pazienti e le loro patologie – è già stata inaugurata nei densi lavori di Gaston Bachelard. Egli ha mostrato l'esistenza di complessi (complesso di Charon, complesso di Ofelia, complesso di Lautréamont ecc.) senza il bisogno d un manuale diagnostico o anche di un paziente… complessi rivelati unicamente dallo stile linguistico.
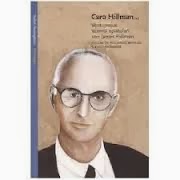
Nessun commento:
Posta un commento